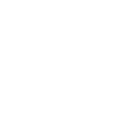L'Uomo delle Oche: Edizione Italiana di: Das Gänsemännchen
L’Uomo delle Oche (Das Gänsemännchen, 1915) è uno dei romanzi più intensi e meno conosciuti di Jakob Wassermann, autore di spicco del panorama letterario tedesco tra Otto e Novecento. Al crocevia tra romanzo di formazione, ritratto psicologico e allegoria esistenziale, l’opera racconta la vita di Daniel Nothafft, un giovane di umili origini che manifesta fin da ragazzo un talento musicale profondo, quasi sacro, e che cerca di affermare la propria vocazione artistica in un mondo che non lo riconosce, non lo capisce e spesso lo respinge.
Il soprannome “l’uomo delle oche” richiama, con tenerezza e ironia, la condizione iniziale del protagonista: un ragazzo di campagna che pascola oche, come nella celebre statua di Norimberga da cui il romanzo prende il nome. Ma al di là del titolo pittoresco si cela un’opera di grande complessità, dove la parabola personale di Daniel diventa metafora universale della lotta dell’artista — e dell’individuo sensibile — contro i vincoli della società borghese, della famiglia, dell’ignoranza e dell’indifferenza.
Wassermann tratteggia con finezza il percorso interiore di Daniel: la scoperta della musica come necessità esistenziale, il contrasto con la madre che non riesce a comprenderne le aspirazioni, lo scontro con un mondo incapace di accettare l’irregolarità, la vocazione, la purezza. L’arte, nel romanzo, non è un passatempo o una professione: è un destino, qualcosa che chiede tutto e non promette nulla. Daniel è un personaggio tragico non perché fallisce, ma perché non vuole scendere a patti con l’utile, il normale, il conveniente.
Scritto durante la Prima guerra mondiale, L’Uomo delle Oche riflette il malessere di un’intera civiltà che sta crollando, e anticipa con lucidità molte delle inquietudini del XX secolo: la crisi dell’individuo, il ruolo dell’artista, la solitudine dell’incompreso. Wassermann, con uno stile lirico e malinconico, costruisce un romanzo che non offre consolazione, ma una visione limpida e dolorosa della condizione umana.
Questa nuova traduzione vuole riportare alla luce un libro dimenticato, restituendogli lo spazio che merita nella tradizione letteraria europea. L’Uomo delle Oche è una storia che parla ancora oggi, a chiunque si sia mai sentito fuori posto, eppure chiamato da una voce più alta, più profonda, più vera.
Il soprannome “l’uomo delle oche” richiama, con tenerezza e ironia, la condizione iniziale del protagonista: un ragazzo di campagna che pascola oche, come nella celebre statua di Norimberga da cui il romanzo prende il nome. Ma al di là del titolo pittoresco si cela un’opera di grande complessità, dove la parabola personale di Daniel diventa metafora universale della lotta dell’artista — e dell’individuo sensibile — contro i vincoli della società borghese, della famiglia, dell’ignoranza e dell’indifferenza.
Wassermann tratteggia con finezza il percorso interiore di Daniel: la scoperta della musica come necessità esistenziale, il contrasto con la madre che non riesce a comprenderne le aspirazioni, lo scontro con un mondo incapace di accettare l’irregolarità, la vocazione, la purezza. L’arte, nel romanzo, non è un passatempo o una professione: è un destino, qualcosa che chiede tutto e non promette nulla. Daniel è un personaggio tragico non perché fallisce, ma perché non vuole scendere a patti con l’utile, il normale, il conveniente.
Scritto durante la Prima guerra mondiale, L’Uomo delle Oche riflette il malessere di un’intera civiltà che sta crollando, e anticipa con lucidità molte delle inquietudini del XX secolo: la crisi dell’individuo, il ruolo dell’artista, la solitudine dell’incompreso. Wassermann, con uno stile lirico e malinconico, costruisce un romanzo che non offre consolazione, ma una visione limpida e dolorosa della condizione umana.
Questa nuova traduzione vuole riportare alla luce un libro dimenticato, restituendogli lo spazio che merita nella tradizione letteraria europea. L’Uomo delle Oche è una storia che parla ancora oggi, a chiunque si sia mai sentito fuori posto, eppure chiamato da una voce più alta, più profonda, più vera.
Condividi questo libro
Recensioni e articoli
Non ci sono ancora recensioni o articoli
Altri libri di Jakob Wassermann
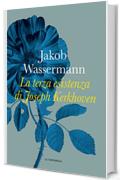
La terza esistenza di Joseph Kerkhoven
La terza esistenza di Joseph Kerkhoven è l’ultimo lavoro di Jakob Wassermann, pubblicato postumo in Olanda dopo il rifiuto del suo storico editore tedesco. E, insieme a Il caso Maurizius ed Etzel Andergast, compone una trilogia legata dal filo rosso dei personaggi, che tornano di volume in volume a segnare una straordinaria continuità stilistica e una deliberata e inquietante coincidenza con la...
Jakob Wassermann — La Tartaruga